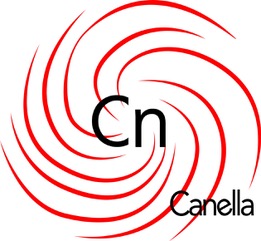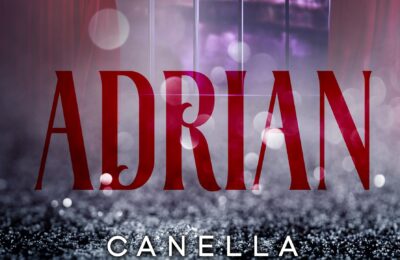Gionni
Bentornati tra i miei angoli smussati.
C’è un articolo, nel mio blog, che ha ottenuto un numero di visualizzazioni piuttosto elevato, e si chiama “Rap, uno strumento di protesta”.
È da tempo che la musica Rap ottiene consensi. Credo che il motivo principale sia legato al tipo di linguaggio utilizzato; un linguaggio vero e autentico in grado di abbattere le barriere del finto perbenismo e di quella stucchevole ipocrisia di cui è infarcito il mondo.
Ebbene, dovete sapere che ho provato a fare la stessa cosa nella scrittura, usando un linguaggio altrettanto autentico e affidandolo a un protagonista, Gionni, immerso in un ambiente “difficile”, in cui dovrà lottare con i denti e con le unghie per sopravvivere.
Un romanzo inedito che ho pensato di pubblicare, un pezzo alla volta, nel mio blog per dare modo alle persone di leggerlo gratuitamente. In cambio, vi chiedo un parere sincero. Per capire quanto un linguaggio del genere possa attecchire anche nella letteratura.
Cominciamo con una breve trama e i primi tre capitoli; affido a voi il compito di farmi capire se dovrò continuare, pubblicando anche i capitoli successivi, o se sarà meglio fermarmi qui.
Il giudice sovrano è e sarà sempre il pubblico.
Buona lettura, cari smussatori di angoli.
Breve trama:
Gionni è un ragazzo diciassettenne cresciuto con un padre assente, una madre che di mestiere fa la puttana, e pochi amici. Vive nella zona Gad, uno dei quartieri più problematici di Ferrara. Il grattacielo, costruito a pochi passi dalla stazione ferroviaria, è simbolo di degrado soprattutto sociale.
Al Gad sono gli africani a comandare, ma la politica locale fa di tutto per abbattere la loro egemonia. Un consigliere comunale contatta Gionni per affidargli un incarico importante: organizzare una squadra che possa ridimensionare l’orgoglio degli extracomunitari.
Gionni tentenna, indeciso se accettare o meno la proposta; da una parte teme di cacciarsi nei guai, ma dall’altra pensa che potrebbe essere una buona occasione per farla pagare al padre.
Tra nuovi incontri, alleanze, amici e nemici, la vita del protagonista subirà un cambiamento radicale e significativo.
Più la mosca si dimena più la ragnatela la imprigiona.
Quando il ragno si avvicina, il destino della mosca è segnato,
e a nulla servono gli ultimi disperati tentativi di fuggire.
1
Giugno 2019
Gionni
Un pugno tremendo mi centra in pieno volto. Mi accartoccio su me stesso e mi ritrovo steso a terra, con la lurida suola dell’africano a premermi la tempia.
«Stronzo di un italiano. Ripetilo se hai il coraggio.»
«Siete feccia» sussurro a denti stretti. «Il nuovo sindaco ve la farà pagare.»
«Zitto.»
Un calcio nel fianco mi toglie il fiato. La punta della scarpa si conficca a fondo, emetto un gemito che si disperde tra i palazzi del Gad.
Qui la gente non sente. Non vede. Si barrica in casa ringraziando il Signore di essere ancora viva.
Non ho speranze che qualcuno accorra in mio aiuto.
«Sei uno stupido» mi rimprovera l’africano.
Sputo di lato per ripulire l’asfalto dal passaggio di quegli esseri disgustosi. Un ghigno malefico mi contrae il volto. Sputo ancora, un senso di eccitazione mi pervade.
Lo schiaffo del Gad è violento, ma non lo sento.
I piedi che mi circondano sono tanti; mi massacreranno fino a togliermi la vita?
Un peso insostenibile mi comprime al suolo e mi schiaccia i polmoni. «Non respiro» protesto con un filo di voce.
Continuano a menarmi, ormai sono allo stremo. Servirebbe un miracolo o…
«Basta. Volete ucciderlo?»
Lo riconosco: è Samuel.
«Fratello, che cavolo vuoi?» protesta il capo degli africani.
«Voglio che lasci in pace il mio amico.»
«Questo stronzo è tuo amico?»
«Sì, Zulu.»
«Zulu, il vero stronzo sei tu!» sbotto, una nuova dose di energia mi scorre nelle vene dopo che l’africano grassoccio si è sollevato e ha portato il suo culo altrove.
Samuel mi aiuta a rialzarmi, poi mi avvolge con un braccio per sostenermi. «Come stai, bro’?»
«Abbastanza bene.»
«Che cazzo è successo?» chiede l’amico.
Zulu mi indica. «Chiedilo a lui.»
«Ho esultato per la vittoria della Lega» sottolineo con una vampata di orgoglio.
«Non solo» precisa il capo degli africani.
«Detto noi.. he says to us…»
«Obi sta dicendo che ‘sto stronzo ci ha definiti merda e ha detto che verremo bruciati.»
«Zulu, sei serio?» Samuel spalanca la bocca, e stiracchia i lineamenti in un’espressione incredula.
Il nemico color carbone annuisce.
Samuel mi guarda, una nota triste gli offusca lo sguardo. «Gionni, è vero?»
Sorrido, sono fiero di avere avuto il coraggio di dirglielo in faccia. Non sono come quei conigli che quando tornano al Gad si barricano in casa facendosela addosso per la paura. Io, a differenza di loro, non abbasso la testa quando passo vicino agli africani. Non ho bisogno di spiare dalle finestre per capire cosa sta succedendo. Io scendo in strada e affronto il nemico.
«Mi hai deluso, bro’.»
Le parole di Samuel ridimensionano la mia gioia.
L’amico nigeriano, il solo amico che ho al Gad, toglie il braccio e se ne va scuotendo impercettibilmente la testa.
Resto a fissarlo, con i pugni chiusi, ripetendomi che sono un mostro. Ma non posso farci nulla perché detesto mio padre. E odio tutti quelli come lui.
La realtà ammazza le illusioni.
L’odore acre di piscio che impregna ogni angolo mi ricorda, ogni santo giorno, che sono spazzatura al pari degli africani.
Sono una mosca imprigionata nella ragnatela del Gad; ma io riuscirò a fuggire da questo posto di merda.
Tre mesi dopo
Gionni
La pioggia che si infrange contro i vetri risveglia la mia parte cattiva.
Il cuore pulsa: un colpo veloce, uno lento, a intervalli regolari. Una lama che entra ed esce. Stringo la testa tra le mani, la scuoto per liberarla dagli incubi, grido ma non mi sento.
Fisso il soffitto, la lampada che oscilla da una parte all’altra è un cattivo presagio. Buio. Tenebre che mi avvolgono e mi tolgono il respiro.
Chiedo pietà. Il mio cuore è saturo, non c’è posto per altro dolore. Deve scoppiare? È questo che vuoi, mondo di merda? Mi hai messo in ginocchio, ma non esultare perché mi sto rialzando. È la rabbia a tenermi in piedi. È la mia unica ragione di vita.
La pioggia aumenta; dentro di me sta piovendo a dirotto.
Il cielo borbotta, singhiozza, ruggisce, assume le sembianze di una bocca famelica che tenta di divorarmi.
Devo salvarmi, ma prima devo calmarmi cercando di tenere sotto controllo il tremore.
Afferro un bicchiere e lo scaglio a terra. Mi sento meglio, ma il fatto che fosse di plastica non mi appaga. Non scaccia la voglia di rivalsa, non contribuisce ad accrescere la mia autostima: chiunque avrebbe il coraggio di gettare qualcosa che non si può rompere.
Prendo un altro bicchiere e lo stringo con forza, la consistenza è perfetta; il rumore dei cocci di vetro che si spargono sul pavimento mi soddisfa. Piego le labbra in un sorriso, una liberazione che dura poco, purtroppo.
La pioggia cessa, ma non dentro di me. Una saetta improvvisa mi contorce le budella in un brivido. Una scossa che risale la spina dorsale scaricandosi sul collo. Mi massaggio, ma il dolore non passa.
La luce ovattata che entra dalla finestra riflette la mia ombra contro la parete; un’ombra sbiadita che si confonde con quella della misera tenda di un pessimo color cioccolato. Il volto riflesso sul muro si allunga, emette una risata isterica che mi spaventa. Sono davvero io, quello? Allargo le labbra, la frustrazione mi ha modificato i lineamenti. Sì, sono io. E ne sono orgoglioso. Sei… il mio idolo Gionni.
L’idolo di me stesso? Che cazzata. Che cazz… stringo i denti, la sagoma scura è scomparsa dalla parete, ora si riflette tra i miei pensieri: una lunga ombra, occhi rossi che stanno prendendo fuoco.
Ansimo, ammazzo la paura con il coraggio.
La lampada si riaccende, torna la luce. Esulto. Mondo di merda, hai capito che il buio non mi spaventa.
Stringo la mano e ammiro il pugno: le nocche sembrano brillare. Un nuovo sorriso mi fa splendere il volto. L’affanno scompare, torno a respirare come prima. Mi sento rinascere, serve una scarica di adrenalina, devo gridare per liberarmi, conosco un solo modo per riuscirci: seleziono, tra i preferiti del cellulare, il link di Lose yourself.
Look.
If you had.
One shot.
Or one opportunity.
To seize everything you ever wanted.
In one moment.
Would you capture it.
Or just let it slip?
Eminem insegna: la rabbia è speranza.
La rabbia segna il confine tra i presunti cattivi e i finti buoni. Noiose etichette della società, tatuaggi indelebili che qualche stronzo ti appiccica addosso. Mi definiscono cattivo: lo fa l’insegnante, lo gridano i miei compagni, lo sostiene mamma, anche Elia e Samuel se lo lasciano sfuggire, di tanto in tanto.
Solo Don Gigi non l’ha mai detto, ma forse lo pensa.
Non è un problema, lo ritengo un complimento. Perché è grazie alla cattiveria che mi spingerò oltre i limiti e arriverò dove gli altri non oserebbero. La mia mente spiccherà il volo… adoro perdermi tra le nuvole, lo considero un privilegio.
Una scintilla mi folgora i pensieri: l’alba è l’inizio di un nuovo spettacolo.
Tiro fuori dal jeans il pezzo di carta stropicciato per annotare la frase. Sospiro, questa è la medicina migliore; l’unica che mi fa sentire un uomo vero e non un pupazzo scaraventato in un angolo.
Troppe volte vengo gettato come immondizia.
Sentirsi diversi è favoloso, ma non lo è quando sei ancora piccolo. Da bambino, il desiderio è sentirsi uguale agli altri.
Non sono mai stato come gli altri: è… stato terribile.
Piango e mi incazzo. Afferro un altro bicchiere e lo spiaccico a terra. Tanto mamma non c’è. Come al solito.
Il rumore mi fa andare in frantumi, sono io a essermi rotto.
Dentro di me continua a piovere.
Una pioggia che diventa tempesta e si abbatte, violenta, sul cuore.
2
Katia
Papà ammise, sottovoce, che aveva perso il lavoro. Tremava, tremava dentro di sé, lo sentivo anche se faceva di tutto per mascherare il suo stato d’animo. Evitava di guardarmi negli occhi, ma il suo sguardo spento non mi sfuggì. Me lo tatuai nel cuore, e il cuore tossì.
«Purtroppo cambieranno un po’ di cose.»
La mano di mia madre scese sulla mia schiena in una carezza. La sentii deglutire, quando papà aggiunse quelle poche parole: «Andremo a vivere al Gad.»
«Là gli affitti costano meno» mormorò mamma.
«Molto meno» precisò papà con un sospiro.
Non parlai, non domandai nulla anche se la testa si riempì di dubbi.
Un piccolo cenno di assenso fu sufficiente per dipingere un piccolo sorriso sul volto di papà. Il sorriso di chi si era tolto di dosso la vergogna di confessarsi davanti alla figlia. Come se perdere il lavoro fosse una colpa. Come se l’azienda avesse chiuso per demerito suo anziché della grave crisi economica che aveva colpito l’Italia intera.
Avrei voluto consolarlo, ricordargli che, nonostante la sfortuna, restava un uomo eccezionale; invece fui costretta ad andarmene per soffocare il pianto nel cuscino della mia camera.
Da allora mi sono informata, ho letto molti articoli sul Gad per cercare di saperne di più di una zona in cui non sono mai stata, tranne i rari momenti in cui l’ho attraversata di sfuggita, per andare in stazione.
Tra qualche giorno ci trasferiremo; al momento, è come se fossi stata scaraventata in un frullatore che sta macinando i miei sentimenti.
Paura.
Il Gad è un posto orripilante, da evitare, chi ci vive vale poco più di niente per il resto della città. Spaccio, risse e auto della polizia sono all’ordine del giorno.
Là la normalità coincide con ciò che il popolo dei benpensanti ritiene anormale.
Il Gad è il figlio brutto, maleducato e incivile che Ferrara ha nascosto in un angolo, ma è il primo posto che i turisti visitano dopo essere arrivati in stazione; non è un controsenso?
Tristezza.
Lasciare la casa che mi ha visto crescere non sarà facile. Conserverò i ricordi, li porterò con me, dentro al mio cuore saranno al sicuro.
Curiosità.
Come sarà la mia nuova vita? Chi incontrerò? Gli africani come ci accoglieranno?
Qualcuno sta bussando, credo di sapere chi è.
«Avanti.»
Sorrido quando sbuca il volto di mamma.
«Come ti senti?» domanda con un filo di voce.
Appoggia il vassoio sulla mia scrivania. Rifiuto i biscotti con una smorfia, mi accontento di sorseggiare il tè.
«S-strana» replico in un balbettio.
«A chi lo dici.»
La ritrovo sul letto, al mio fianco, mi sta accarezzando una spalla.
«Mamma… ho paura.»
«Ti confesso una cosa: anch’io ne ho.»
«Anche tu?»
«Sì, ma sono certa che insieme supereremo questo brutto momento.»
«Lo spero e voglio crederci, ma… sono triste. Tutto questo» allargo il braccio «mi mancherà.»
Mamma si solleva e si avvicina al quadro appeso sopra al letto. «Avevi…»
«Quattro anni.»
Annuisce. «Eravamo appena venuti a vivere qui.» Sospira. «Io e tuo padre eravamo felici. Finalmente avevamo trovato una casa grande, e di lavoro, allora, ce n’era in abbondanza.»
«Non credevo che a diciassette anni sarei finita al Gad.» Mamma mi osserva con gli occhi ridotti a due fessure ma resta in silenzio. «Non ho niente contro gli africani» preciso, «ma da quello che ho letto, e che sento, non è un posto visto di buon occhio.»
«Lo so, Katia. Dicono sia pericoloso, ma… non avevamo alternative. Spero» si inginocchia e mi stringe il volto tra le mani «che sia solo una sistemazione provvisoria.»
Il cuore batte forte. Tempesta. Che mi distrugge.
«Lo spero, davvero» sussurro.
Ci fissiamo intensamente; il suo abbraccio è la coperta che mi ripara dall’aria fredda che spira per congelarmi il cuore.
Andremo a vivere al Gad: le parole di papà tornano a galla per inquinare i pensieri positivi che stavano cercando di sbocciare. Pensieri che appassiscono in fretta.
3
Gionni
Un senso di eccitazione mi pervade quando sollevo la foto di quello stronzo di mio padre e avvicino l’accendino. È stato lui a mandarci a vivere in questo posto di merda. Osservo, con un’espressione sadica, l’angolo che diventa nero e si confonde con il colore della sua pelle: una scarica di adrenalina che nemmeno una riga di coca sarebbe in grado di provocare. Non ho bisogno di drogarmi; bruciare le foto di chi mi sta sul cazzo è sufficiente per sentirmi sollevato.
Odio papà: è per colpa sua se la mia pelle ha questo colore orrendo. Non passa giorno che non vorrei strapparmela a morsi.
Non sono nero ma nemmeno bianco: una via di mezzo che mi fa vomitare.
«Cos’è questa puzza?»
La maniglia si alza e si abbassa, si abbassa e si alza, è un orgasmo pazzesco. Perché so che nel mio regno lei non potrà entrare. Sono io, solo io, a decidere chi può farne parte.
«Gira la chiave, stupido!»
«Vai via.» Non aggiungo che è una troia, in fin dei conti è mia madre.
Anche se puttana lo è di professione. È grazie a quei soldi sporchi, di maiali che hanno il coraggio di definirsi uomini, se non siamo ancora morti di fame.
«Se non apri sfondo la porta.»
Sorrido perché quello stronzo di mio padre è quasi bruciato del tutto e perché mamma non riuscirà a buttarla giù. La sua minaccia è poco più fastidiosa del ronzio di un insetto. Una donna pelle e ossa, col vizio dell’alcol, non ha la forza necessaria. Spesso le parole non vengono supportate dai fatti; a lei capita ogni volta.
Dice che mi vuole bene, ma non lo dimostra.
Dice che vuole starmi vicino, ma sono rari i momenti in cui stiamo insieme.
Dice che sono prezioso, ma il denaro lo è di più.
Dice che lo fa per me, ma gode come una cagna quando qualcuno la scopa.
Mi fingo divertito per evitare di piangere.
«Che cavolo ridi?» sbotta, il tono esasperato.
«Fatti i cazzi tuoi e vai via.»
«Mi hai stancato.»
Sbarro gli occhi, sento montare una collera pazzesca. Non puoi dirmi una cosa del genere, non ne hai il diritto. Appiccico le labbra contro la porta e urlo: «Vattene! Te lo ripeto per l’ultima volta.»
«Altrimenti?»
«Ti ammazzo di botte.» Non saranno mai abbastanza in confronto a quelle che mi hai dato tu, quando ero piccolo.
«Sono tua mamma.» Comincia a piangere. «Merito un po’ di rispetto» aggiunge con una voce stentata.
«Infatti, non ti ho ancora menato. Ma ti consiglio di andartene subito, potrei ripensarci.»
«Sono preoccupata per te. Non lo capisci?»
Prende a pugni la porta, poi si lascia andare, rassegnata. Le unghie che strisciano sono graffi che mi lacerano il cuore.
Preoccupata per me? Dove cazzo eri quando ero un bambino ed ero costretto a barricarmi in casa perché avevo paura?
«Apri, ti prego.»
«Vai in chiesa a pregare.» E confessa i tuoi peccati. «Voglio stare solo.»
È tanto difficile da capire?
«Ti supplico» insiste battendo ancora le nocche nella porta.
Smetto di considerarla e mi getto a letto vinto dalla solita sfiancante discussione con una donna che a stento fatico a riconoscere.
Lei è Irene Trota ed è mia madre. Dovrebbe essere la donna più importante della mia vita.
E quella manica di imbecilli che hanno bisogno di pagare per riuscire a fare centro con il loro lurido cazzo la chiamano “la Trottola”.
Uomini di merda, piccoli quanto formiche che si credono leoni. Vedono una donna e si cagano addosso; per accrescere la loro autostima, hanno bisogno di pagare una puttana.
Mio padre è… uno di questi.
La testa è una scatola colma che non riesco a svuotare. Mi sollevo e vado a sedermi davanti al misero tavolo che ha l’assurda pretesa di assomigliare a una scrivania, e schiaccio il pulsante sul vecchio computer scartato dalla collega di mamma.
Ci mette una vita ad accendersi, attendo impaziente rigirando i pollici.
Apprezzo il regalo, ma pensare alla zoccola più zoccola della zona – detto dalla Trottola – come a una sua collega, mi fa sorridere. In ogni caso, le sono grato perché il computer è fondamentale: non avrei potuto creare un canale su YouTube, non avrei potuto trovare un posto sicuro nel quale rifugiarmi dopo ogni tempesta.
E pensare che mamma crede serva per giocare.
Questo non è uno scherzo, ma un modo per sopravvivere: condivido la musica, e i miei pensieri, nella speranza che altri si riconoscano nei testi. Le mie parole li terranno a galla nonostante la voglia di lasciarsi andare e affogare. Assurdo?
Non è assurdo desiderare di annegare; a volte è la via più semplice, o la sola percorribile, per tentare di raggiungere la felicità.
Quando guardo la chitarra, appoggiata in un angolo della stanza, smetto di avercela con mamma. È stata lei a regalarmela, è stata lei a portare a casa il computer. Mamma mi ha donato la vita, poi se l’è ripresa, però mi ha lasciato un appiglio da afferrare per portarmi in salvo ogni volta che le onde cercano di inghiottirmi.
Penso a tutte le volte che sono andato in pizzeria con gli amici e fingevo di avere già mangiato perché non avevo soldi. Mi sentivo diverso, soffocavo le lacrime per non farle scendere davanti agli altri; quante umiliazioni ho dovuto subire?
Cicatrici profonde che mi hanno reso cinico, freddo, insensibile.
Socchiudo gli occhi in cerca di ispirazione, quando li riapro agito le dita sulla tastiera: mi hai regalato la vita ma non le scarpe per camminare.
Ogni volta che ripenso a quella notte in cui mamma ha ammesso che sono stato un errore mi sento morire.
Il bastardo ti ha annaffiato con il suo seme, poi è fuggito come un vigliacco.
Ha assicurato che mi ha voluto tenere perché mi ha considerato un regalo del destino.
Non sei brava a recitare.
Mi definisci un dono ma pensi che il destino ti abbia fatto uno scherzo.
Si è preso gioco di te… gioco di me.
Non auguro a nessuno una mamma così.
Sei il mio tormento,
un faro spento che non mi indica la via.
Mentre diceva che ero un regalo piangeva. Non era gioia quella. Il valore di un pianto sincero lo riconosci. Quelle lacrime contenevano dolore.
Il mio cuore perde un pezzo ogni volta che il ricordo torna a galla.
Afferro la chitarra e trasformo le parole in musica.
Le note tengono a bada la rabbia.
Questa pagina ha 2,506 letture totali